Erano amici Enrico e Amedeo. Di quelle amicizie che durano per sempre. Amici come lo possono essere due che hanno fatto tante cose insieme. Cose appassionanti. Cose per cui si rischia la pelle. Cose che tatuano nel cuore la parola “Compagno”.
Amedeo era più grande. Era nato in un’epoca buia, quando la Prima Guerra Mondiale era cominciata da poco. In campagna, in mezzo al niente e campi di grano. Da due mesi aveva sposato Iole, compagna di scuola di Enrico, che era stato testimone al loro matrimonio.
Enrico aveva sempre il sorriso stampato sulla sua bella faccia. Dov’era lui, era festa. Era di una famiglia genericamente cattolica e per il suo carattere aperto e gioioso gli volevano bene in tanti. Era diventato partigiano quasi da bambino e la politica per lui era un modo di esprimere generosità, freschezza e spontaneità.
Faceva caldo quella domenica a Ponticelli, anche poco dopo l’alba. Enrico e Amedeo si erano alzati presto: erano già tutti indaffarati. Era il gran giorno. Nella piazza del paese, dalle 4 del pomeriggio fino a notte fonda ci sarebbe stato l’appuntamento a cui stavano lavorando da giorni: la Festa de l’Unità. Si videro appena dopo che il bar del paese aveva aperto per prendere un caffè. Amedeo sarebbe andato a fare il solito giro della domenica: casa per casa a diffondere l’Unità e poi sarebbe corso in piazza a dare una mano per gli ultimi ritocchi: dovevano essere pronti i chioschi per la vendita di vino, pizza fritta e panini; doveva essere sistemata la Ruota della fortuna e lo spazio per il tiro degli anelli alle bottiglie: Anche la pesca era uno spazio fondamentale per raccogliere soldi per finanziare il Partito. Ma soprattutto doveva essere una serata di divertimento e di festa per tutti.
Enrico invece aveva rimediato un Furetto (un ciclomotore della IsoMoto che non godeva di molta fortuna sul mercato), che aveva un aspetto già scassato, nonostante non fosse vecchissimo: ma a forza di essere usato ogni giorno per molte ore nelle strade bianche e piene di buche tra la Vallata del Santerno e la bassa imolese dimostrava già molti anni. Era contento, eccitato, perché aveva appuntamento con Riccardo, che portava da San Marino i fuochi artificiali che avrebbero reso la fine della serata meravigliosa, lasciando tutti quelli che guardavano in alto a bocca aperta.

Il Furetto aveva un motore a due tempi di 65 cc di piccola potenza. Ebbe uno scarso successo malgrado lo slogan “Furetto…lo scooter perfetto”.
Faceva già caldo quella mattina. Ma come due fratelli erano contenti. Più che affiatati: complici. Facevano la cosa che più piaceva loro: organizzare nel concreto una cosa che faceva stare bene le persone, tanta gente sarebbe arrivate da Fabbrica, Codrignano, Linaro, dalla Marana, dallo Sbago… da tutte le località della campagna attorno.
Faceva già caldo quando si salutarono. Non ci fu nessuna cerimonia: si sarebbero rivisti di lì a poche ore. Era normale.
Enrico partì con quel motorino lento e pernacchiante. Doveva fare molta strada e soprattutto, dopo, dovevano tornare in due su quel trabiccolo. Ore dopo incontrò Riccardo, che aveva fatto lo sminatore e per il Partito aveva imparato ad gestire le serate pirotecniche nelle Feste de l’Unità della Romagna, che cominciavano a diventare numerose e sempre molto partecipate. Non si erano mai visti, ma era facile individuare uno in stazione a Forlì con un sacco in spalla sotto la pensilina, con la sigaretta in bocca, appoggiato al muro, all’ombra. Si salutarono e sistemarono il sacco tra il manubrio e la sella e Riccardo prese posto sul portapacchi. Non era una situazione comoda, ma piano piano sarebbero arrivati.
Faceva caldo sulla via Emilia e il rumore del motore impediva anche di chiacchierare. All’imbocco della Strada Montanara dopo ore di viaggio si sentiva una strana puzza di olio bruciato. I due erano tranquilli: ormai mancava poco. Passarono l’ospedale di Imola, costeggiarono il canale proseguirono sulla strada costeggiando il rudere della villa sulla destra, un posto bellissimo, con quei pini che lo rendono dolce e delicato che fa sempre venir voglia prima o poi di andare lì e rimettere a posto tutto per farne un posto da favola. Oggi è come allora.

Enrico Farolfi, da Giorgio e Cecilia Dall’Osso; nato il 28 settembre 1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nel battaglione Montano della brigata SAP Imola e operò nell’imolese. Partigiano dal 20 luglio 1944 al 14 aprile 1945. (Foto tratta da Il Momento)
Arrivarono al podere Giarona, a non più di 700 metri dalla piazza della festa. Fu un’altra buca, fu il caldo del motore arroventato dalla distanza e dal calore della giornata, fu una scintilla… ma il sacco si incendiò da sotto, da dove non si poteva vedere e i fuochi esplosero come una bomba. Il rumore si sentì a chilometri di distanza. Il motorino si schiantò in fiamme e i due furono sbalzati a qualche metro.
Ad accorgersi che quel botto veniva della strada e che si trattava di un incidente fu il medico condotto della zona: il dottor Bottao, che abitava proprio lì vicino: a cinquanta metri. Rapidamente arrivarono in tanti e si creò presto una gran confusione. Urla e silenzi di fronte a quei corpi per terra. Ai bambini fu intimato di stare lontano, di non avvicinarsi.
Il boato lo sentì bene anche Amedeo. Faceva molto caldo quel pomeriggio, ma si sentì gelare il sangue. Non sapeva cosa fosse successo ma cominciò a correre sulla Strada Montanara e fu tra i primi ad arrivare sul luogo dello scoppio. Vide il suo compagno a terra, rantolante: tra la polvere e il sangue. La scena era terrificante, per certi versi simile ad un momento che avevano vissuto insieme quando erano partigiani e le esplosioni erano di bombe e mitragliatori. L’uomo si avvicinò all’amico. Gli accarezzò il capo e cercò di calmarlo, di consolarlo, di fargli coraggio. Dopo un tempo che apparve infinito arrivarono i soccorsi e portarono Enrico in ospedale ad Imola.
Ad Amedeo era già chiaro quanto la situazione fosse disperata. Con la sua bicicletta faceva avanti indietro da Ponticelli all’ospedale di Imola: pochi chilometri ma fatti a tutta per provare a scaricare la tensione. Era nell’anticamera della stanza quando arrivò
Veraldo Vespignani (qui si può sentire la sua voce in un brano della lunga chiacchierata che facemmo vent’anni va). Enrico tutto sommato era lucido, nonostante le massicce dosi di morfina che attutivano il dolore. Quando vide il sindaco addirittura si preoccupò di non essere troppo in disordine e con una mano fece per sistemarsi i capelli. “Sindaco. Come mi dispiace… La nostra festa… Avrei voluto che fosse bellissima…”
L’amico era di nuovo lì la mattina dopo quando quel ragazzo che avrebbe compiuto 24 anni esattamente il mese dopo, dormiva ancora e da quel sonno non si sarebbe più svegliato.
-

-
Il titolo de Il Diario
-

-
EPSON MFP image
Il momento della perdita è anche quando le persone più coinvolte si danno una scossa, mettono tutta l’energia possibile nel sistemare i particolari. E’ quando si affrontano tutte le cose pratiche per evitare di fermarsi a pensare. Amedeo parlottò con i compagni della sezione e insieme decisero di andare dalla famiglia. “Lo sapete – disse rivolto soprattutto alla madre – Enrico avrebbe voluto che del suo funerale si occupasse il Partito e avrebbe voluto che fosse un’occasione per i compagni di ritrovarsi in piazza con le bandiere rosse e i garofani”. La madre rimase perplessa, tutti i funerali della famiglia erano sempre stati fatti in chiesa. Parlò con il marito e alla fine senza entusiasmo accettarono la proposta.
Faceva caldo il pomeriggio del 30 agosto 1950 a Ponticelli dove le persone a migliaia si ritrovarono per salutare Enrico Farolfi. Fu una manifestazione di popolo imponente. La politica, la passione, il dolore si mescolarono al rispetto per una persona che si faceva voler bene.
Ecco l’episodio triste, drammatico, doloroso poteva essere finito qui. Ma anche in un remoto paese della bassa valle del Santerno “la storia non ha nascondigli” e il dolore delle persone a volte non è sufficiente, deve aggiungersi qualcosa.
La scena del secondo finale di questa vicenda si svolge la domenica 4 settembre 1950 alla messa nella chiesa di Ponticelli nel momento dell’omelia. Il sacerdote – secondo quanto mi è stato possibile ricostruire – parla dell’incidente, del lutto per la scomparsa di un parrocchiano, del dolore della famiglia e punta l’indice su quell’uomo che ha convinto la famiglia a non svolgere la funzione religiosa, un uomo mandato dal demonio. “Che quell’uomo, già scomunicato in quanto comunista, possa essere dannato!”
…
Amedeo Caprara era mio padre e oggi, 18 febbraio 2016, mentre pubblico questo post, avrebbe compiuto 100 anni.

La famiglia di mio padre. Riconosco mio nonno, Alessandro Caprara, il secondo da sinistra, poi in piedi la figlia piccola Ida Caprara (che era del 1914 ed è morta a 99 anni) con il marito Agostino Bianconcini (presumo che questo fosse il giorno del loro matrimonio. Seduta, a sinistra, Assunta Cristiani, mia nonna, morta nel 1950. Penso che la fotografia sia degli anni Trenta.
***

Amedeo Caprara nel 1950
In questi giorni ho cercato di rimettere a posto i ricordi, di scartabellare tra i documenti che mi sono restati nei cassetti, di parlare con un po’ di persone, di cercare sul web e alla Biblioteca di Imola riferimenti che mi aiutassero a mettere a posto un po’ di pezzi: per trovare conferme e appigli alla mia memoria, anche perché ormai quei fatti sono annacquati tra i miei pochi neuroni funzionanti a già 18 anni dalla sua scomparsa. Sono contento di averlo fatto: è stato modo per dedicare ancora un po’ di tempo a lui.
***
Amedeo che visse nella balena
La prima vita. Era nato a Castel Guelfo, quinto di cinque figli, in una famiglia di braccianti. Il padre Alessandro era un uomo che aveva radici in quella bassa povera e malsana: tra i campi, alberi da frutta, risaie e zanzare. La madre aveva un cognome indicativo: Cristiani, ma come se non bastasse si chiamava Assunta. La sola cosa che conosco di lei è lo sguardo severo che ho visto nella foto ricordo distribuita al suo funerale. D’altra parte è morta dieci anni prima che io nascessi.
La mattina all’alba faticava già nel campo, prima di andare a scuola. Il lavoro gli piaceva, molto più dello studio. Non era affatto stupido, ma faceva un po’ il “patacca” e quando fu promosso in terza elementare fece talmente arrabbiare il maestro che lo rimandò in seconda… così ne ebbe abbastanza e decise che la sua vita da grande sarebbe cominciata lì.
Lavorava come un mulo da quando aveva 8 anni: tutto il giorno. La sera cercava di divertirsi e col tempo la sua grande passione diventò il ballo. Mentre nelle case della “borghesia” imolese si ascoltava di nascosto Duke Ellington e Glen Miller, nelle aie della campagna e nelle balere messe sù alla buona si ballava il liscio. In questi posti dove d’inverno la nebbia del fumo delle Nazionali era più fitta di quella del novembre padano tutte le sere si tirava a tardi, fino a non poterne più.
Con il crescere era diventato piuttosto bello e le ragazze se ne accorgevano: i suoi vent’anni sono stati molto intensi. Teneva al suo aspetto e, di fronte ai miei capelli lunghi di diciottenne, si vantava nel raccontarmi che lui alla mia età tutti i giorni passava dal barbiere a farsi ritoccare i baffi (all’Amedeo Nazzari) e i capelli. Credo che fin da allora indossasse la cravatta tutti i giorni (quando non aveva gli abiti da lavoro).

Penso che questa sia una foto dell’albania e Amedeo è il primo in basso a sinistra
Detestava i fascisti, ma negli anni ’30 non credo che si occupasse di politica. Il senso del dovere veniva prima di tutto. Per forza di cose il 10 agosto del 1939 partì militare, nei bersaglieri, e rimase sotto le armi per più di quattro anni. All’inizio le cose non gli andavano così male: lo destinarono nei Balcani quando fu proclamato il Protettorato Italiano del Regno d’Albania, poi andò in Grecia, ma era entrato in cucina e aveva imparato a fare tante cose, evitando così la prima linea. In seguito tornò a fare servizio militare, ma nella sanità, in una base in Veneto: era lì l’8 settembre quando Badoglio annunciò l’armistizio con gli anglo-americani e l’esercito italiano si sbriciolò.

E’ il primo a destra e probabilmente è una foto scattata in Veneto, poco prima dell’8 settembre 1943
Per quanto ne so io – lui non ha mai parlato molto di quel periodo – l’11 settembre del 1943 era già scappato da Padova e tornato ad Imola dove cominciò a fare lavoretti in campagna per sopravvivere. Dal giugno del 1944 si aggregò ai gruppi partigiani ed entrò nel
battaglione Montano della brigata SAP Imola. Era un clandestino e la sua libertà durò fino ai primi giorni di ottobre del 1944, quando fu catturato, incarcerato per un paio di giorni nella Rocca di Imola e poi fu trasferito a Fossoli (nei pressi di Carpi, in provincia di Modena) dove rimase fino al 27 ottobre 1944 quando fu deportato in Germania.
Dal 28 ottobre 1944 comincia la sua odissea. Davvero non so se fu per discrezione, per paura di riesumare ombre che aveva nel cuore e nella testa o per rimozione totale di quei giorni terribili, ma lui non raccontava quasi nulla di quella sua esperienza. Tanto che io credevo che si fosse trattato di un periodo molto breve e invece andando a spulciare i documenti ho scoperto che in quel campo di concentramento tedesco rimase per ben 7 mesi.
Più volte lo sollecitai per sapere se si ricordava dove si trovasse quell’inferno e lui riusciva solo a rispondere “in Bassa Sassonia”. Per deduzione ho ricostruito che si potrebbe trattare del
campo di concentramento di Belsen, quello dove finì i suoi giorni Anna Frank.
Una sola cosa, di quel posto maledetto, ricordava bene: un particolare della la sua fuga. Dovrebbe essere avvenuta durante i primi giorni di maggio del 1945. Raccontava che insieme ad un altro prigioniero con cui riusciva a comunicare solo attraverso le occhiate, probabilmente polacco, riuscirono a fuggire e si acquattarono in un fossato e stettero lì immobili per oltre un giorno, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Ad un certo punto sentirono delle voci ed un rumore di cingoli e motore. Si sentì perduto. Poco metri più in là, passò un carro armato, lui presumeva tedesco. Nessuno del plotone che seguiva il carro vide i due fuggiaschi… Alcune ore dopo, faticosamente e si alzarono senza sapere se lì sopra li avrebbe attesi un proiettile o la libertà.
Uscire da quel fosso era come nascere un’altra volta.
Barcollando cominciarono a vagare nel buio. Per loro fortuna arrivarono nei pressi di una casa di contadini dove furono soccorsi ed accolti con un certo riguardo: li rivestirono, li nutrirono e da lì faticosamente Amedeo ripartì cercando qualche mezzo per ritornare a casa. Il suo peso normale era attorno agli 80 kg, tornato ad Imola, salì sulla bilancia e l’indicatore segnava 40 chilogrammi.
In quel fosso finì la sua prima vita e ne cominciava una nuova.
Una botta in testa

Una foto tessera di quegli anni. “La confusione mentale dovuta alla guerra è una sindrome molto frequente. Durante la Seconda guerra mondiale e i conflitti successivi, questa confusione di guerra ha lasciato il posto alle psicosi deliranti acute e in qualche caso rivestivano un aspetto schizofrenico più inquietante. Esse, normalmente, regrediscono rapidamente. Tutti questi quadri clinici acuti sono accompagnati da manifestazioni somatiche di spossatezza e sono seguiti da amnesia più o meno importante”.
La seconda vita. Dopo un trauma tanto violento tornare alla vita normale non è stato facile. I primi mesi sono stati dedicati ad una vera e propria riabilitazione alla normalità. La Germania ha lasciato dei segni profondi e dolorosi nel suo corpo: la tubercolosi gli ha risparmiato un solo polmone e le ombre di quella prigionia avevano per molti mesi intaccato l’equilibrio psichico di un uomo giunto a raccogliere le ultime risorse possibili per poter sopravvive. Piano piano, con pazienza e con molta volontà e tenacia, viaggiando in molti ospedali e incontrando situazioni mostruose, come solo una guerra può generare colpendo l’umanità più umile e sfortunata. Vide talmente tante miserie da sentirsi un privilegiato, un uomo fortunato. E questo – accanto alla convinzione di non volere figli per i rischi che un medico gli aveva pronosticato – lo aiutò a ritrovare serenità ed equilibrio.
Secondo il Libretto di Lavoro (rilasciato dal Ministero delle Corporazioni) il 27 luglio del 1945 ottiene il suoi primo lavoro presso la
Società Anonima di Elettrificazione (impresa nata alla fine degli anni ’20 con lo scopo di elettrificare la linea ferroviaria Bolzano-Brennero, ma poi col tempo si era sviluppata ed era divenuta una delle aziende che hanno realizzato le infrastrutture che hanno permesso il boom economico dell’Italia). Poi è costretto a fermarsi per diverso tempo e ricordo che fu un periodo complicato di farmaci e ricoveri. Poi si riprese e fu ingaggiato con contratti brevi, precari e di lavori ad alto rischio, ma certamente che procuravano un discreto stipendio.
Dopo quel primo rapporto di lavoro con la SAE ne sono seguiti diversi altri. Il montatore è un po’ come il marinaio, si passano settimane lontano da casa e quando si è giovani e senza particolari vincoli non mancavano le occasioni di svago… In fondo a me sono arrivati chiari i principi saldissimi che valorizzano il rispetto delle regole e delle persone, la lealtà, la giustizia e l’importanza del lavoro. D’altra parte sono anche grato a mio padre che mi ha insegnato anche che la vita va vissuta meglio possibile, i soldi vanno spesi quando ci sono e essere felici è molto meglio che essere tristi. Senza dimenticare l’inestimabile valore del cazzeggio.
Accanto al lavoro cresceva anche l’attenzione e la partecipazione alla vita del Partito Comunista Italiano. Per diverso tempo non è stata una priorità assoluta, ma l’esperienza partigiana e le amicizie che si erano cementate nel tempo facevano crescere l’esigenza di dare il proprio contributo per costruire un società più giusta, ma con azioni, non con tante chiacchiere. Pare retorica, ma io credo che allora fosse proprio così: contava fare. In fondo la guerra aveva resettato tante cose, tante convinzioni e, per molti versi, era l’occasione per ripartire con una “innocenza reale” nel guardare la vita, nel lottare per l’utopia di costruire un mondo nuovo, migliore. C’era una profonda buona fede e la stessa ingenuità che quella generazione ha messo nel proprio impegno politico e sociale hanno contribuito non poco alla crescita dell’Italia.
All’inizio del 1950 – ancora quel decisivo anno – muore a 65 anni mamma Assunta. Amedeo “fa l’amore” da quasi un anno con un ragazza di Linaro che si chiama Iole e decidono di sposarsi. Lo fanno a giugno: vanno in comune in bicicletta loro due e i due testimoni. Passano a salutare i genitori di lei e poi si concedono un picnic al Parco delle Acque Minerali.
La vita scorre. I lavori si susseguono e permettono alla coppia di girare l’Italia: vanno per alcuni mesi a Bolzano e poi dal capo opposto del Paese: a Cefalù. Sono esperienze belle e che permettono di vivere anche momenti di serenità e cementare nuove amicizie.

Amedeo fu saldatore alla Benati, la prima volta alla fine anni ’50 e poi fino al 1969
Nell’ottobre del 1957 succede una cosa apparentemente senza importanza. Amedeo ha ottenuto un contratto come saldatore nelle Officine Benati, un’azienda che già dalla fine dell’800 fabbricava aratri, e che sotto la guida di Treggia pur non essendo un po’ traballante stava cercando personale. Accettò per stare un po’ a Imola e come sempre si buttò con entusiasmo e vigore nel lavoro. Un pomeriggio si era girato di scatto e un collega che passava di lì con un lungo tubo lo urtò violentemente in testa. Una botta molto forte. Non cadde per terra, ma certamente il colpo si fece sentire per tutta la giornata e a parte il bernoccolo che passò in un paio di giorni tutto sembrava normale.
Si susseguirono i lavori e a casa le insistenze di Iole si facevano sempre più pressanti per avere un figlio. Alla fine, quasi 10 anni dopo il loro matrimonio, abbattute le ultime resistenze di Amedeo arrivò la gravidanza. Io sono sempre stato convinto che la cosa che fece cambiare atteggiamento ad Amedeo rispetto alla paternità fu il fatto che io nacqui lo stesso giorno della fondazione del PCI: il 21 gennaio. Quel giorno del 1960 nonostante gli oltre 20 centimetri di neve, nonostante il freddo, nonostante la levatrice gli avesse impedito di stare in casa ad assistere al parto perché si sarebbe trovato ad ostacolare il suo lavoro, per mio padre fu il giorno più bello della sua vita. Ero sano, ero maschio ed ero nato il giorno del suo partito. Andò al bar a pagare da bere a tutti. Era gasatissimo al punto che voleva chiamarmi Carlo (come Marx). Sono ancora riconoscente a mia madre che riuscì ad evitare almeno questo… si misero d’accordo su un particolare: che la lettera iniziale del mio nome fosse uguale a quella del cognome. Non ho mai capito il motivo di questa trattativa… tant’è…

Amedeo e Iole, a occhio e croce potrebbero essere i primi anni ’70
Nel 1961 morì anche mio nonno Alessandro. Non posso ricordare nulla nemmeno di lui. Non so bene come potesse essere possibile, ma negli ultimi mesi della sua vita abitava con noi in una casa fatta di camera e cucina in via Fornace Gallotti, 6. Credo che quella morte sia stata un grande dolore. Molto più di quello che mi padre intendesse mostrare.
Io crescevo e se c’è un ricordo nitido è l’immagine di mio padre che la sera arrivava a casa dal lavoro e si sedeva prendeva l’Unità o Rinascita e leggeva. Leggeva. Leggeva. Ma un’altra cosa mi aveva impressionato: sempre più spesso la sera soffriva di lancinanti mal di testa. Dovevano davvero essere dei dolori insopportabili perché c’erano momenti in cui diventava rosso paonazzo e sembrava quasi non riuscire a resistere.
Ancora il suo destino era quello di pellegrinare in giro per medici ed ospedali per capire quale fosse la causa di questi dolori. Passano i mesi e gli anni e finalmente a novembre del 1965 al Bellaria di Bologna il professor Giulio Gaist riuscì a diagnosticare che si era formato un angioma nel cervello a seguito di un trauma che aveva lesionato una vena. Il dolore era dovuto alla pressione che questa massa esercitava su punti sensibile ed era assai probabile che la massa fosse in crescita e che quindi la situazione fosse destinata ad aggravarsi. Gaist fu molto chiaro: in quell’epoca un’operazione chirurgica sarebbe stato un rischio notevole, ma non intervenire significava solo aspettare il peggio. La sola domanda che fece mio padre fu: “Se mi opero, quante speranze ho di salvarmi?” Il professore rispose che se si voleva essere ottimisti, il 50%. Non ci pensò un minuto: guardò in faccia sua moglie che lo aveva accompagnato al consulto e rispose: “Professore, quando facciamo l’intervento?”
La sua seconda vita stava finendo su un tavolo operatorio e la sentiva rapidamente dissolversi perché l’anestesia era potente e le luci dei fari che illuminavano quei medici bardati con mascherine e lenti si spegnevano, nonostante lui cercasse di tenere gli occhi aperti e non sapeva se poi ci sarebbe stato un domani.
Il castello
La terza vita. Si rinasce ancora, ma serve sempre una grande volontà e una forza d’animo straordinarie per vivere veramente.

Io con Amedeo durante una gita sul Monte Grappa nel 1972
L’operazione era riuscita perfettamente. Era uno dei primi interventi al cervello a cielo aperto che rimetteva a posto una malformazione di un vaso sanguigno con quelle caratteristiche. Il professor Gaist portò quel caso in numerosi convegni e durante le visite di controllo che continuarono per anni, tra i due si creò un rapporto di amicizia e di stima reciproca.
Anche imparare a cavalcare la tigre: andare con decisione al cuore del problema per risolverlo quando si identifica e affrontare la paura con lucidità (e forse un pizzico di follia) è una cosa di cui sono debitore a mio padre. Non so se sempre sono stato coerente e all’altezza, ma ho cercato di esserlo. Mi è capitato spesso ho pensato a come ci si trova a dover giocare una scommessa con il destino. Una scommessa che non permette repliche: altro che Sliding Doors…
Anche questa riabilitazione non fu breve. Amedeo tornò a lavorare alla Benati che nel frattempo era in impetuosa crescita per la gestione di
Renato Bacchini (una specie di Gianni Agnelli di Imola) alla fine del 1966 – cinquant’anni fa – aveva perduto un po’ di ampiezza di campo visivo, ma le sue condizioni erano molto buone e la sua autostima a livelli elevati.
Durante la quaresima del 1967 il sacerdote che faceva il giro nelle case per la benedizione pasquale si trovò senza un chierichetto e quando arrivò a casa mia ero con mia madre (che in quel periodo faceva la sarta, a casa) e chiese a lei se io fossi stato disponibile a fare il giro con lui e un altro bambino che già lo accompagnava. “Se lui vuol venire lo può decidere da solo…” Decisi di andare. Non nego che l’esperienza mi piacque. Tornai a casa trionfante con dolci, caramelle, piccoli giocattoli e altri trofei. Quando mio padre arrivò a casa dalla fabbrica gli mostrai con orgoglio il frutto del mio lavoro pomeridiano. Ricordo perfettamente (nonostante siano passati così tanti anni) che era un venerdì. Amedeo non fece una piega. Il suo volto non tradiva nessuna espressione né di riprovazione, né di soddisfazione. Andò in bagno (che si raggiungeva scendendo quattro gradini fuori dalla porta). Passarono 3, forse 4 minuti. Aspettai in silenzio cercando la complicità nello sguardo di mia madre, che si limitò a dire: “Hai deciso tu…” Rientrò. “Sei andato col prete di casa in casa e ti sei divertito? Molto bene: da domenica vieni con me a vendere l’Unità!” La cosa mi sembrò una specie di sentenza inappellabile… ed in effetti tutte le domeniche da quando avevo 7 anni e due mesi fino a quando ne ho avuti più di 18, tutte le domeniche – con la neve o con il sole – sono andato a distribuire l’Unità a chi lo prendeva regolarmente e a chiedere di comprare il giornale a chi invece non era abituato a farlo… Evidentemente il rapporto di Amedeo con la Chiesa, 17 anni dopo quella famosa omelia di Ponticelli, non era ancora risolto…
Nell’ottobre del 1969 – presto per una persona senza problemi, ma abbastanza tardi per uno che aveva avuto la sua vita “sanitaria” da “paziente professionista”, come si auto definiva – è andato in pensione. Già da anni però era in contenzioso con lo Stato Italiano affinché fosse riconosciuta la “Pensione di guerra”. Fu alla fine del 1970 (evidentemente gli anni con lo zero dietro erano sempre decisivi) gli fu assegnata
la V categoria e gli furono inviati tutti gli arretrati. Fu un’occasione di una piccola emancipazione economica. Andammo ad abitare un una casa nuova: ebbi per la prima volta una mia stanza e rimasero le risorse per fare un piccolo investimento: la realizzazione di un allevamento di circa 500 galline da uovo, nella valle del torrente Sellustra. Non fu una buona idea: tra predatori (fu la prima volta che sentii parlare della donnola), epidemie, alti costi di gestione e crescenti tensioni tra i tre soci, la cosa non funzionò. Ma di quei giorni ho un bel ricordo.

Ad una delle tante manifestazioni dell’ANPI, negli anni ’90
In ogni caso, essere collocato in quella V categoria non lo soddisfaceva per niente: un suo avvocato lo convinse che c’erano tutte le condizioni per accedere ai privilegi della I categoria. Cominciò quindi una sequela di ricorsi, di attese crescenti, di delusioni cocenti, di speranze che si rinnovavano… Cominciarono periodicamente “viaggi della speranza” sia a Bologna che a Roma. Docce scozzesi che si susseguirono per oltre 20 anni. La I categoria rappresentava l’accesso ad un benessere famigliare, ad una sicurezza che avrebbe accompagnato anche mia madre finché fosse vissuta (le famose pensioni di reversibilità) e un riconoscimento “pubblico” ai sacrifici e alle sofferenze che aveva vissuto nella sua prima vita.
La sua pratica era come se fosse immersa nell’acqua melmosa di un porto delle nebbie e in cuor mio non sono mai stato convinto che saremmo riusciti a ripescarla. Tanti anni dopo, doveva essere il 1986, durante il primo periodo che passato a Roma a lavorare, mio padre mi chiese di andare da un avvocato che lo seguiva di tanto in tanto e gli mandava comunicazioni rassicuranti. Non so che ruolo avesse, ma frequentava la Corte dei Conti. Fu un’esperienza traumatica: abitava in un piano alto di via dei Gracchi, in uno di quei palazzi umbertini che quando entri ti fanno sentire piccolo, insignificante. Presi l’ascensore di ferro battuto ed entrai in un corridoio enorme, nella penombra. Una cameriera in livrea mi fece accomodare in una stanza piena di libri con rilegature antiche e due dita di polvere sopra. Dopo un buon quarto d’ora l’avvocato entrò con un passo lentissimo e una faccia che mi apparve come mummificata. Per me quella fu per sempre la faccia della burocrazia romana. Parlava con voce bassa, quasi incomprensibile: “Ci vuole tempo, la prossima settimana andrò ad esaminare il fascicolo… Certo che con 500 mila lire forse si può guadagnare qualche giorno…” Mi sentivo come nel gabinetto del dottor Caligari.
La sentenza che chiudeva definitivamente (e negativamente) questa storia, che avrebbe fatto impallidire Franz Kafka e il suo Castello praghese, arrivò nel 1996. mio padre non la prese troppo male, ma certamente il suo privato “sole dell’avvenire” tramontava e questa attesa infinita che si chiudeva fu quasi una liberazione.

La terza vita di Amedeo, forse, fu quella più serena. Ci fu ancora molto impegno nel Partito dove conobbe tanti compagni (
uno in particolare), ma riusciva a vedere anche le storture e i difetti di quella comunità che tanto ha amato e sulla quale ha sempre riposto molta fiducia. Nell’89 si schierò a favore della Svolta, ma soprattutto si impegnò nella crescita dell’
ANPI (la sola organizzazione di cui ancora oggi io abbia la tessera). Fin che ha potuto ha coltivato le sue passioni: per il ballo – prima di tutto – la lettura, le passeggiate in montagna.
Non conobbe mai suo nipote e questa è forse la cosa che mi dispiace di più. E’ per questo che il racconto che ho fatto in questa giornata speciale lo dedico ad Alessandro, perché ha avuto un grande nonno. E io ne sono molto orgoglioso.





















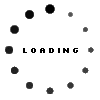
Grazie Claudio
Grazie mille Claudio per questo racconto, mi ha mostrato uno “zio Amedeo” sconosciuto e mi ha permesso di aggiungere un pezzettino al mosaico familiare.
Che bella storia. Storia di una vita dura e di tanta passione. È un onore x me poter leggere queste righe che rivelano tanto di te e della tua famiglia. Grazie per aver condiviso col mondo qualcosa di così personale.